Ripartiamo
dall’ultima slide della prima parte con l’immagine di Enrico VI Hohenstaufen,
figlio di Barbarossa e padre di Federico II. Il sovrano regge con la mano destra lo scettro imperiale e con
l’altra un enigmatico cartiglio che sembra evocare le colonne del Tempio di
Salomone. Per avvalorare questa ipotesi sarà tuttavia necessaria una premessa
teorico musicale.

L’immagine ‘A’, a
sinistra, mostra la sesta corda ‘Mi’ della chitarra contrassegnata da 4
punti equidistanti in corrispondenza dei punti della base della Tetraktys.
Intercettando alternativamente i due punti centrali - laddove si trovano le
colonne salomoniche evidenziate in verde - questi produrranno la nota ‘Si’,
ossia la quinta nota sopra l’accordatura della corda (Mi, Fa, Sol, La, Si):
da qui il codice ‘VV’ associato alle colonne del Tempio di Salomone. L’immagine
‘B’, a destra, mostra come i due punti centrali siano rispettivamente a 2/3
dal punto più lontano: la frazione 2/3 è infatti indicativa del rapporto
geometrico dell’intervallo di quinta. La sovrapposizione delle due misure nel
terzo mediano della corda conferiscono alle colonne la valenza simbolica di
‘coincidenza degli opposti’.

Ritornando
all’immagine di Enrico VI Hohenstaufen, il codice ‘VV’ associato alle colonne è
criptato nelle orecchie alla base del cartiglio: alla prima ‘V’ allude l’ampia
piega in basso della fascia destra; alla seconda ‘V’ allude la piccola piega
della fascia sinistra platealmente stretta dal sovrano fra l’indice e il
pollice della mano destra. Ancora alle colonne salomoniche allude infine lo
scettro gigliato in analogia ai capitelli del Tempio descritti
nel Primo Libro dei Re.

La damnatio
memoriae che colpì gli Hohenstaufen dopo la sconfitta degli ultimi rampolli
della casata, Manfredi e Corradino, rispettivamente figlio e nipote di Federico
II, non impedì un rigurgito di politica cesaropapista in chiave filobizantina.
L’occasione fu il concilio di Ferrara e Firenze (1437-39) per la riunificazione
delle chiese latina e ortodossa. La Cappella dei Magi (1459) di Benozzo
Gozzoli rievoca quella circostanza effigiando la famiglia Medici e alcuni
barbuti dignitari bizantini tra cui, forse, Giorgio Gemisto Pletone
l’ispiratore della scuola neoplatonica greca di Mistrà nel Peloponneso.

Al
seguito della delegazione bizantina guidata dall’imperatore Giovanni VIII
Paleologo figura anche il dottissimo Basilio Bessarione che, dopo il concilio,
sarà nominato cardinale con funzione mediatrice tra Oriente e Occidente. Fu
così che Bessarione poté mettere in atto una politica di fatto ambigua: se da
un lato con fare guelfo assecondava le mire di Pio II Piccolomini volte alla
riunificazione della prima e della seconda Roma (alias
Bisanzio) sotto l’egida papale, dall’altro con fare ghibellino esercitava pressione
politica perché fosse restituita a Bisanzio la titolarità del Sacro Romano
Impero.

Bessarione
contava soprattutto sul sostegno di potentati italiani che, secondo la storica
di Bisanzio Silvia Ronchey, formavano una sorta di Grande Oriente
filobizantino. Primo fra tutti il signore di Rimini Sigismondo Pandolfo
Malatesta cugino di Cleopa Malatesta moglie dell’aspirante al trono di
Costantinopoli Teodoro II Paleologo. Fervido seguace della dottrina
neoplatonica di Gemisto/Pletone, Sigismondo ne tumulò le spoglie mortali in un
sarcofago sulla fiancata del Tempio Malatestiano di Rimini, spoglie che egli
stesso aveva trafugato a Mistrà durante una spedizione militare contro i
turchi.

L’affiliazione
neoplatonica di Sigismondo Malatesta è indiziariamente provata dalla sigla
personale formata dalle prime due lettere sovrapposte del suo nome ($).
La ritroviamo duplicata sullo stemma personale nonché replicata centinaia di
volte nel Tempio riminese che papa Pio II aveva stigmatizzato degno «di
adoratori dei demoni». La sigla sigismondea denuncia la sfrontatezza del
signore di Rimini nell’essersi assimilato al codice ‘VV’: infatti, se per un
verso la S suggerisce il numero 5, per altro la I ammicca
alla sagoma di una colonna. Sotto questo aspetto c’è poi chi finanche ipotizza
il ruolo precorritore della sigla sigismondea dell’originario simbolo valutario
americano.

Nella cella
dinastica del Tempio Malatestiano di Rimini si trova il celebre affresco
pierfrancescano con Sigismondo in ginocchio di profilo al centro della scena
che prega l’omonimo suo protettore san Sigismondo re dei Burgundi. Che si
tratti di un gioco ‘al doppione’ è presto detto. Le due colonne salomoniche
sono surrogate dalle lesene ai lati di Sigismondo mentre il codice ‘VV’ è
criptato nelle 5 scanalature che le solcano invece che le solite ‘6’
come negli affreschi di Masaccio e negli edifici del Brunelleschi. Al codice
‘VV’ rinviano sia le sigle sigismondee sullo stemma in alto al centro sia il
gesto delle mani giunte (5 dita su 5 dita) del signore di Rimini.
Quanto ai due Sigismondo - l’uno santo, l’altro peccatore – il richiamo è alle
colonne Jachin e Boaz tradizionalmente associate ai ruoli di ‘maestro’ e
‘allievo’.

Ad
avallare il rinvio delle lesene alle colonne salomoniche concorre lo sfondo
architettonico che fa presagire lo sviluppo delle campate laterali come
suggeriscono i due verdi festoni parzialmente visibili. In questo modo il
numero delle lesene sale a 4, tanti quanti sono punti equidistanti della
base della Tetraktys. Trovandosi le due lesene centrali rispettivamente a 2/3
della base rispetto alla lesena più lontana (rammentiamo che la frazione
2/3 esprime il rapporto musicale di quinta), il rinvio è appunto al codice
‘VV’.

Riguardo ai due
levrieri, uno bianco e l’altro nero orientati in senso opposto accucciati alla
base della lesena a destra, oltre a rinviare al principio di coincidenza degli
opposti occultano il codice ‘VV’ associato alle colonne salomoniche. Infatti,
le curve dorsali ricalcano il grafico (evidenziato in rosso) degli intervalli
di quinta presenti nel diagramma della lira del pitagorico Filolao,
diagramma che, qualche decennio più tardi, comparirà nella Scuola di Atene
di Raffaello sulla lavagnetta retta dal giovane accanto a Pitagora.
Sempre al
principio di ‘coincidenza degli opposti’ si ispirano infine i simboli dello
scettro, associato al principio maschile, e del globo associato
al principio femminile, nelle mani di san Sigismondo, simboli
controbilanciati sul lato opposto dalla ‘torre/maschio’ dentro la
‘finestra/tonda’.

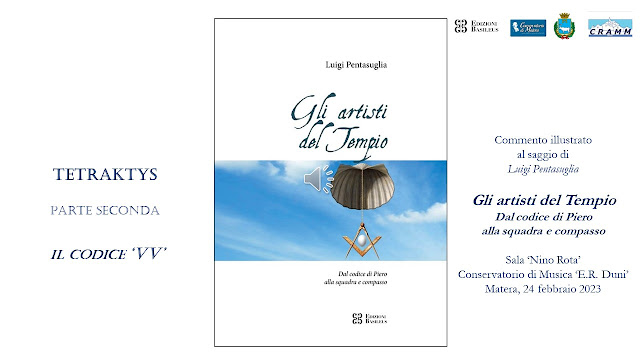














Nessun commento:
Posta un commento